Alcuni pensano che in Italia ci siano molti crimini tra italiani e che i reati siano soprattutto opera di stranieri perché la cittadinanza si concede dopo 10 anni. I dati però smentiscono questa idea: la criminalità dipende da integrazione, marginalità e condizioni socio‑economiche, mentre l’Italia resta tra i Paesi più restrittivi al mondo nel concedere la cittadinanza.
PER CHI HA POCO TEMPO
-
Alcuni affermano che molti reati in Italia siano commessi da (ex) stranieri perché la cittadinanza si concede dopo 10 anni. L’idea è che i reati siano ascritti come commessi da cittadini italiani perché in realtà sono stranieri a cui è stata concessa loro la cittadinanza dopo 10 anni di permanenza. I dati ufficiali mostrano però che la maggior parte dei reati non è commessa da cittadini italiani appena naturalizzati, ma da cittadini italiani e stranieri di lunga permanenza. Non esiste quindi una relazione diretta tra tempo per ottenere la cittadinanza e tassi di criminalità.
-
Alcuni hanno paragonato l’Italia ad altri paesi, sostenendo che la cittadinanza altrove sia più restrittiva. Tuttavia l’Italia è tra i paesi più restrittivi al mondo per la naturalizzazione, con requisiti come 10 anni di residenza, integrazione linguistica e buona condotta. In altri paesi europei la cittadinanza si ottiene più rapidamente (3–5 anni) e con requisiti meno complessi.
-
Il mito che i cittadini stranieri commettano più reati perché ottengono tardi la cittadinanza è quindi smentito dai dati: la criminalità dipende da fattori socio-economici, integrazione, povertà e marginalità. La correlazione indica una ma non implica necessariamente un rapporto di causa-effetto
PER CHI VUOLE APPROFONDIRE
Nel dibattito pubblico italiano è frequente l’affermazione secondo la quale una parte significativa della criminalità in Italia sia legata a persone straniere senza cittadinanza, e che ciò dipenderebbe da una concessione della cittadinanza troppo tardiva — dopo 10 anni — il che porterebbe ad una sovra‑rappresentazione delle persone straniere non naturalizzate nel sistema penale, e alla convinzione che i cittadini italiani “autentici” siano più virtuosi. Tale argomentazione è spesso evocata in trasmissioni televisive e interviste, e riflette una correlazione intuitiva tra cittadinanza, integrazione e comportamento sociale. Tuttavia, i dati disponibili suggeriscono che l’insieme dei fatti sia assai più complesso e che alcune affermazioni richiedano chiarimenti.
Innanzitutto va evidenziato che, dal punto di vista normativo, la cittadinanza italiana per residenza risulta tra le più restrittive nei paesi europei: per un cittadino extracomunitario che desideri richiedere la cittadinanza italiana è necessario un periodo di almeno dieci anni di residenza legale ininterrotta in Italia. Il termine può essere ridotto, ad esempio quattro anni per cittadini UE, cinque anni per rifugiati o apolidi, ma la regola ordinaria conferma la soglia dei dieci anni. Questa durata rappresenta un significativo fattore di selezione e differenziazione nell’accesso alla cittadinanza: non è dunque corretto affermare che “si dà subito la cittadinanza” come fattore centrale nel modello italiano.
Per quanto riguarda i dati disponibili sulla criminalità in rapporto alla cittadinanza o alla condizione di stranieri nel sistema penale, occorre precisare che la presenza di cittadini stranieri nei dati di detenzione, segnalazione o arresto non si traduce automaticamente in un fatto semplice come “gli stranieri commettono più reati perché ancora non cittadini”. Alcuni studi indicano che la percentuale di cittadini stranieri denunciati o arrestati risulta più alta rispetto ai cittadini italiani, ma ciò non riguarda specificamente la cittadinanza acquisita dopo dieci anni, né tiene conto della complessità dei fattori socio‑economici e di integrazione.
Un dato utile riguarda la quota di stranieri tra la popolazione detenuta: circa 19.740 persone straniere erano detenute in Italia, pari al 31,6% della popolazione detenuta nel Paese, mentre gli stranieri residenti in Italia costituiscono circa il 9% della popolazione complessiva. Questa discrepanza può alimentare la percezione che “gli stranieri siano responsabili della maggior parte dei reati”, ma da ciò non si può dedurre che la cittadinanza tardiva da dieci anni sia la causa principale.
Va anche considerato che la gran parte dei reati è comunque commessa da italiani o da persone cittadine italiane, semplicemente perché la maggioranza della popolazione residente è italiana. Alla luce di questi elementi, quindi, l’argomento secondo cui “si danno dopo 10 anni la cittadinanza, quindi i più giovani che commettono reati sono soprattutto stranieri con nuova cittadinanza” appare poco fondato. La cittadinanza si ottiene dopo un lungo periodo, e la correlazione temporale con il crimine risulta debole. La criminalità va analizzata rispetto alla struttura di popolazione, all’età, all’integrazione, alle condizioni socio‑economiche, all’educazione e all’occupazione, non solo alla cittadinanza.
Infine, va chiarito che in confronto con altri Paesi europei, l’Italia è considerata uno dei paesi con requisiti più stringenti per la naturalizzazione da residenza. Al contrario di quanto affermato da alcuni spettatori, la cittadinanza in Italia non è più facile rispetto ad altri stati: è piuttosto restrittiva sia sul piano temporale sia su quello delle condizioni richieste.
In conclusione, la cittadinanza è uno strumento giuridico e simbolico, ma i fattori che maggiormente si correlano con la criminalità sono molteplici: condizioni di marginalità socio‑economica, esclusione, scarsa integrazione, età giovanile, disoccupazione e povertà. Utilizzare la cittadinanza come fattore causale o spiegazione di primo ordine rischia di semplificare troppo una realtà complessa. Per una discussione pubblica più informata sarebbe utile che gli interventi in media si rifacessero ai dati, contestualizzando le proporzioni rispetto alla popolazione interessata e distinguendo tra cittadinanza acquisita, durata della residenza, livello di integrazione, origine geografica e condizioni strutturali.

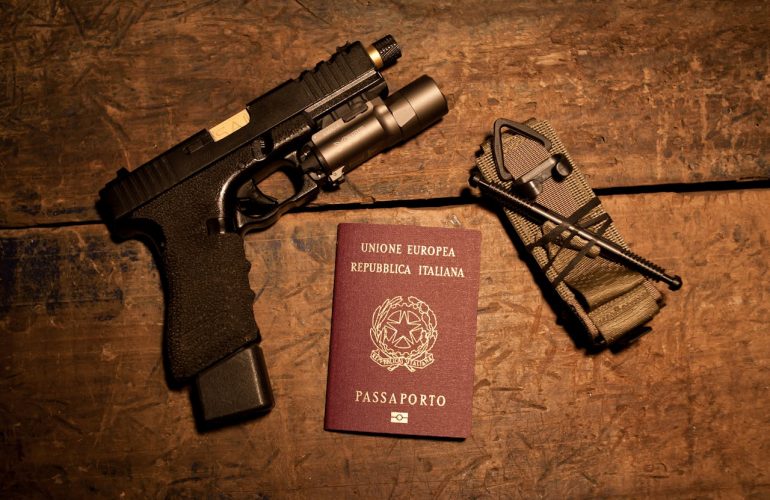
Comments